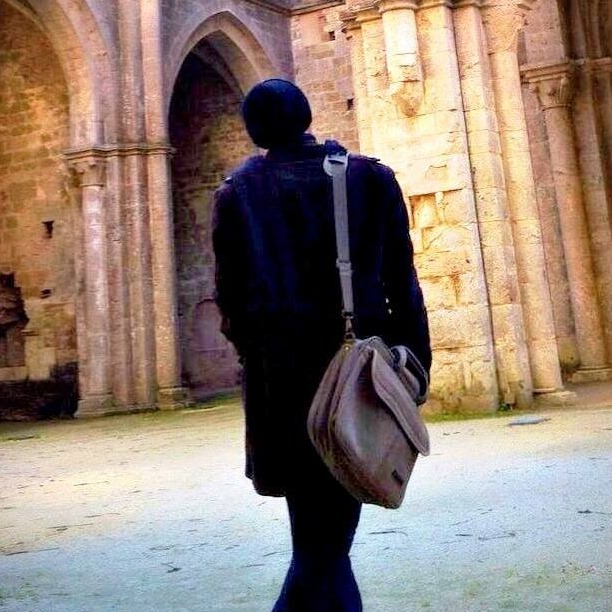La scuola dell'incompetenza

C’è un meccanismo collaudato – per quanto possa essere collaudata una macchina sgangherata – che riguarda il discorso di destra sulla scuola. Data la premessa che la scuola in un dato momento è stata distrutta – mentre era buona la scuola di un tempo – si individua l’origine del degrado attuale in qualche idea o pratica pedagogica progressista che in realtà ha inciso poco o nulla sulla struttura di una istituzione che procede decennio dopo decennio, incrollabile come uno schiacciasassi, dietro l’insegna del "Si è sempre fatto così".
Ne è vittima per lo più don Lorenzo Milani: perché è evidente che la scuola italiana è stata trasformata in una immensa Barbiana. Più di recente Loredana Perla, che il governo Meloni ha messo a coordinare la Commissione di studio che riscriverà le Indicazioni Nazionali (e c’è il sopetto che a lavoro finito non si chiameranno più Indicazioni), se la prende con Tullio De Mauro e le Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica, che quest’anno compiono cinquant’anni e che in cinquant’anni sono state, purtroppo, ben poco applicate nella scuola italiana.
La premessa, questa volta, è offerta dal Censis, il cui ultimo rapporto annuale chiude la scuola italiana nella definizione, non molto adatta all’equilibrio che dovrebbe caratterizzare un istituto di ricerca, di "fabbrica degli ignoranti". "Il 49,7% degli italiani – avverte il Censis – non sa indicare correttamente l’anno della Rivoluzione francese, il 30,3% non sa chi è Giuseppe Mazzini (per il 19,3% è stato un politico della prima Repubblica), per il 32,4% la Cappella Sistina è stata affrescata da Giotto o da Leonardo, per il 6,1% il sommo poeta Dante Alighieri non è l’autore delle cantiche della Divina Commedia"1. Italiani ignoranti, dunque. Ignorantissimi. Di chi è la colpa? Prima di seguire il ragionamento di Perla è bene dare uno sguardo all’idea di scuola di chi è dietro quella indagine.
Giuseppe De Rita è il sociologo co-fondatore del Censis, di cui è diventato presidente del 2007. Nel 2021, in piena pandemia, De Rita apre un incontro del Censis sulla scuola in diretta streaming con un suo lungo intervento dal titolo significativo: Una disperata confusione: la scuola italiana al 2021. Non si può certo accusare De Rita di non mostrare le sue carte. C’è stata in passato, dice, una "infuocata dialettica" sul futuro della scuola. Da una parte c’era chi, come lo stesso De Rita, voleva che la scuola fosse al servizio dell’economia, dall’altra chi ha sostenuto invece l’autonomia della scuola. Il povero De Rita è stato sconfitto. Il risultato è stata una "troppo invasiva scolarizzazione a oltranza" che ha prodotto non solo una istituzione troppo pesante, ma anche e soprattutto un sistema che si è, nelle sue parole, gonfiato in alto, con "tanto liceo e tanta università".2
Sono parole letteralmente incredibili, se pensiamo che la spesa pubblica per l’istruzione rispetto al PIL in Italia si attesta ben sotto la media europea (4,1%, contro una media europea del 4,7%), ma soprattutto se consideriamo i dati, davvero preoccupanti, di una recente (dicembre 2024) indagine Eurostat sull’istruzione terziaria in Europa3, da cui risulta con disperante chiarezza che l’Italia è, dal punto di vista dell’istruzione avanzata, del tutto al di fuori dell’Europa: quasi tutte le regioni italiane hanno un livello di istruzione avanzata simile a quello di Romania e Turchia; le regioni messe meno peggio sono comunque peggiori delle peggiori regioni di Francia e Spagna.
Siamo, insomma, i più ignoranti d’Europa (almeno se consideriamo ignorante chi non ha un concluso gli studi terziari, cosa che si può contestare). Ma discutiamo appassionatamente le idee sulla scuola italiana di chi ritiene al contrario che vi sia in Italia un eccesso di studenti universitari. Siamo in una visione del mondo rovesciata, letteralmente delirante, che è una parte significativa del nostro problema.
Torniamo a Loredana Perla. Se il Censis dice che siamo ignoranti, bisognerà capire perché. "Da qualche parte si annida la causa della sindrome italiana denunciata dal Censis", scrive.4 E dove si annida la causa? Nel fatto che, a causa del povero De Mauro, gli insegnanti italiani hanno smesso di fare grammatica, convertendosi alle tesi progressiste della linguistica democratica. Che in realtà sono, purtroppo, poco conosciute dagli stessi insegnanti di italiano e pochissimo praticate nella scuola italiana. Ed è singolare cercare le cause di un fenomeno in qualcosa che si annida e non in ciò che è sotto gli occhi di tutti. Quello che è sotto gli occhi di tutti è che la scuola italiana è – nonostante don Lorenzo Milani, Rodari, Ciari, Lodi, Danilo Dolci eccetera – ancora centrata sulla consolidata routine lezione-interrogazione-voto. Perché un adulto non sa chi ha scritto l’Infinito (che a quanto pare il 41% degli italiani attribuiscono a D'Annunzio)? Perché si tratta di un semplice dato richiesto a scuola per ottenere un buon voto all’interrogazione. E una volta fatta l’interrogazione quel dato può essere rimosso, esattamente come si rimuove dalla memoria tutto ciò che non serve più. E perché non serve più? Perché la scuola italiana non è riuscita a fare in modo che l’Infinito di Leopardi fosse significativo.
C’è un altro spauracchio ben collaudato del discorso di destra – ma in questo caso anche di buona parte della sinistra – sulla scuola, ed è quello delle competenze. Il disastro, si dice, è dovuto al fatto che abbiamo sostituito le conoscenze con le competenze, per omaggiare il mercato o qualcosa del genere. La verità è che nelle scuole italiane non si lavora per competenze se non quando è proprio inevitabile farlo. Qualsiasi docente di matematica dovrà pretendere dai suoi studenti che sappiano svolgere un’espressione, che è una competenza, così come un docente di latino chiederà di tradurre Cicerone. E non è un caso che le discipline in cui contano le competenze siano quelle in cui gli studenti italiani vanno peggio. Discipline come matematica e latino per gli studenti italiani sono difficili. E lo sono perché richiedono un lavoro diverso rispetto a quello di base della scuola, che è la simulazione dell’apprendimento attraverso la riproduzione orale di un testo scritto.
Ritenere, come fa Perla, che si possano migliorare le competenze linguistiche degli italiani facendo più grammatica – come se davvero se ne facesse poca, peraltro – è un po’ come, di fronte a un ipotetico dato preoccupante sul numero di incidenti automobilistici, raccomandare alle scuole guida di far fare uno studio più attento dei manuali, mentre evidentemente occorrerebbe più pratica. Che è esattamente ciò di cui ha bisogno la scuola italiana: più pratica, principalmente della lingua. E perché sia una lingua viva, occorre che sia una pratica colloquiale, uno scambio di parole (parole che portano il segno dei diversi contesti sociali e culturali, ognuna con il suo colore e il suo odore) in un contesto di confronto aperto. È quello che dolorosamente manca alla scuola italiana: ed è una delle ragioni per le quali è ancora urgente leggere e praticare le Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica.
Note
Si veda la sintesi all’url: https://www.censis.it/rapporto-annuale/sindrome-italiana↩︎
G. De Rita, Una disperata confusione: la scuola italiana al 2021, disponibile all’url: https://www.censis.it/formazione/una-disperata-confusione-la-scuola-italiana-al-2021↩︎
Eurostat, Tertiary educational attainment, age group 25-64 by sex and NUTS 2 region, 12.12.2024, url: https://doi.org/10.2908/TGS00109↩︎
L. Perla, Grammmatica e latino per contrastare l’analfabetismo di ritorno, in "La Gazzetta del Mezzogiorno", 30 dicembre 2024.↩︎
Nell'immagine: Educazione fisica. Scuola elementare di Avellino. Senza data. Indire, Archivio fotografico per la storia della scuola e dell'educazione, collocazione 2-048-021.